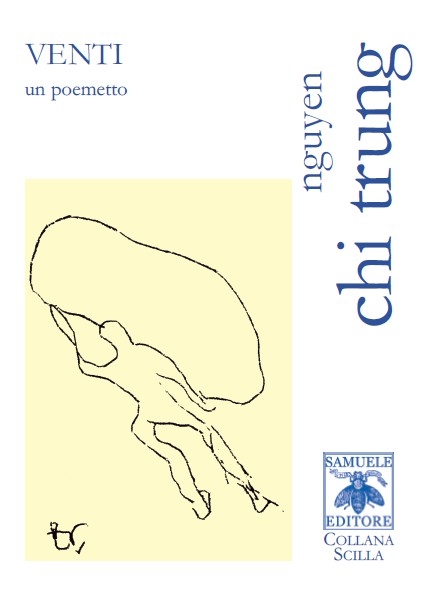Che cosa ha reso la poesia un oggetto di cui non si può parlare? È difficile scrivere una recensione che non sia un tentativo di spiegare il testo, o un arbitrario elenco di vacue suggestioni che potrebbero andar bene per qualsiasi testo. Venti di Chi Trung è una poesia poetologica, e come tale sembra già una recensione di se stessa. C’erano tempi in cui scrivere era utile, dice il poeta, e ci si poteva dedicare con cognizione di causa, ma in questo secolo («presumibilmente l’ultimo») non è più possibile: occorre andare a tentoni, scrivere per affastellamento, senza sapere che cosa si troverà e perché.
Ho riletto l’opera tre volte (due volte e mezza in italiano, mezza in inglese) e credo di aver finalmente superato lo scalino che mi impediva di apprezzarla. Lo scalino, come sempre, era l’idea che la poesia fosse un fenomeno da definire e misurare, anziché un processo da compiere. Nella domanda “che cosa ha reso la poesia un oggetto di cui non si può parlare?” il problema è nella parola ”oggetto”. Lo so: sembra aria fritta che legittima altra aria fritta. (Lo dico alla metà scientifica di me che in questo momento sta bussando con forza sul tramezzo del cervello). Non lo è. Ma non ho modo di spiegarvi perché (come non ho modo di spiegarlo alla mia m. s.): posso solo augurarmi che prendendo in mano il libro riusciate anche voi a saltare lo scalino e a compiere il processo da soli.
Cerchiamo di dire comunque qualcosa di onesto. Venti è un unico poema in 48 quadri. I quadri sono piuttosto brevi (una dozzina di versi ciascuno) e si aprono tutti con un’invocazione:
Venti del cielo, che il cielo separate, [1.]
Venti dell’oscurità, che ulula nel buio, [2.]
Venti del sussurro che sempre più
diventa lieve stanotte, [3.]
ecc. L’ordine non è arbitrario: a volte un quadro rimanda al successivo, ma non è detto; la tentazione di simmetria strutturale (a cui il numero 48 potrebbe far pensare) è elusa; queste non sono le variazioni Goldberg. L’uniformità della texture fa piuttosto pensare alla microtonalità di Ligeti, o (per restare in letteratura) al Salmo 119. Ma sono richiami probabilmente accidentali, che indicano un’inevitabilità più che una consapevolezza.
Per capire l’opera si può partire da un quadro qualsiasi:
27.
Venti, come potete disfare adesso
cose accadute, dare rena all’arenato,
amore all’innamorato? È la parola stessa
che reca dentro la sua responsabilità,
che aumenta la sua nebbia
che si mescola in noi, ponendoci
in una fluttuante situazione.
Non è forse l’intimo del cuore
che mette al bando la carne in esilio?
Tuttavia in quest’inferno
che ci circonda, siamo minacciati
dal misconoscimento finale di ciò
che noi chiamammo anima.
Nguyen Chi Trung, nato nel Vietnam meridionale, cresciuto a Saigon, emigrato in Germania come studente di filosofia e matematica applicata, attualmente residente a Stoccarda, poeta e saggista in vietnamita e in tedesco, ha evidentemente imparato la lingua di adozione sulle pagine Rilke. Non cerca neppure di nasconderlo. Tutto qui profuma di Duinesi. Gli angeli ora si chiamano venti, ma il problema centrale è ancora quello dell’impermanenza dell’uomo e della sua possibile redenzione attraverso la parola, «den gelben und blaun | Enzian». C’è Rilke nell’uso dei participi («dem Gestrandeten | den Strand geben, dem Liebenden die Liebe?»), nelle interrogative retoriche, nella scelta del lessico. Non è un caso. Ma non è neanche il marchio di una poesia derivativa: se le somiglianze sono lampanti, anche le differenze lo sono. La lamentazione, che nelle Duinesi è sviluppata al punto di farsi personaggio, qui appare secca e rappresa. I versi sono brevi e sincopati. Se in Rilke è implicita una teleologia fin dal principio, dieci anni prima dell’”uragano” di Muzot, qui non si capisce se si andrà a parare da qualche parte o se il percorso si avviterà su sé stesso. E non lo si capisce fino alla fine. In Venti manca una Nona Elegia; il problema centrale (spoiler alert) non viene risolto.
Eppure… aspetta un attimo. Rileggi daccapo. Può essere tutto qui? Siamo in un tempo di residui, è vero; un tempo che il vento spazza con mano glaciale mostrando le cose per quello che sono, l’esistenza «[c]ome una noce di cocco seccata | su una spiaggia arsa, togliendo alla stessa poesia il suo presunto potere («La parola è rimasta indietro«), ma non c’è forse anche un altro livello, una prospettiva da cogliere di sguincio? Venti è poesia opaca: può sembrare profonda o superficiale, a seconda. Ora, tu sai che la profondità si può benissimo simulare. Ma la superficialità illusoria no, è un trucco complesso, richiede ingegno. Pensavi di aver svelato un meccanismo, nel confronto con Rilke, e invece era la poesia che svelava te: le tue idiosincrasie, il palato sempre un po’ difficile, il bisogno di individuare schemi o assenza di schemi. Che cosa vi troverebbe un altro? Puoi fidarti del tuo sguardo che decodifica le parole? Cerchi di rispondere, ma sei immerso nelle sabbie mobili fino ai fianchi e continui a sprofondare.
Eccola qui, la parola che manca a sé stessa. Sto cercando di rappresentare come posso un processo che è stato in realtà molto più sottile e ambiguo. I venti non sono l’argomento della poesia: sono la poesia stessa. Lo squilibrio e il disordine dopo la folata sono effetti del processo, che si compie attraverso la parola ma che nel compiersi nega il valore della parola stessa. Se si riesce a infilarsi in questo piano e a rimanere in bolla quanto basta, ciò che si prova è reale e irrevocabile. La distanza tra il lettore e la poesia si annulla. Una lettura non basta, ripeto. Ne servono almeno due, possibilmente molte di più. «Oh nuvole di gas che diventano carne! | Materia che diventa vita!»: subito dopo aver contraddetto l’immortalità dell’anima, Chi Trung si apre a una possibilità di rinascita cosmologica. Ma non è un tentativo di chiudere il cerchio. Anche il tempo non ha una forma: non è rettilineo né ciclico, si sfalda in un moto caotico che è quello dei venti, che tutto annullano e tutto prendono con sé.
Le poesie di Chi Trung non sono “belle”, nel senso in cui non sono “belle” le ultime sonate di Beethoven. La tensione morale fa a meno dell’estetica. La forma (da quel che si intravede attraverso la traduzione) si limita a tenere assieme la materia senza renderla più gradevole. Solo di rado un’immagine fragrante (le gocce di pioggia sul marciapiede, la caduta delle foglie di tamarindo) viene a soccorrere il lettore. Non sono poesie che regalerei a mia madre, insomma. Ma non c’è nulla di aristocratico nella pervicacia con cui l’autore persegue il proprio compito, fuggendo la tentazione del piacevole, del potabile. È l’unico modo, sembra dirci, perché la poesia rimanga tale, e non una spiegazione di sé stessa: un processo, non un oggetto. Perché è questo che noi siamo alla fine, ed è questo il modo di dirlo, se un modo esiste alla fine.
[Guido Cupani]
da http://guidoq.wordpress.com/2014/09/29/venti/