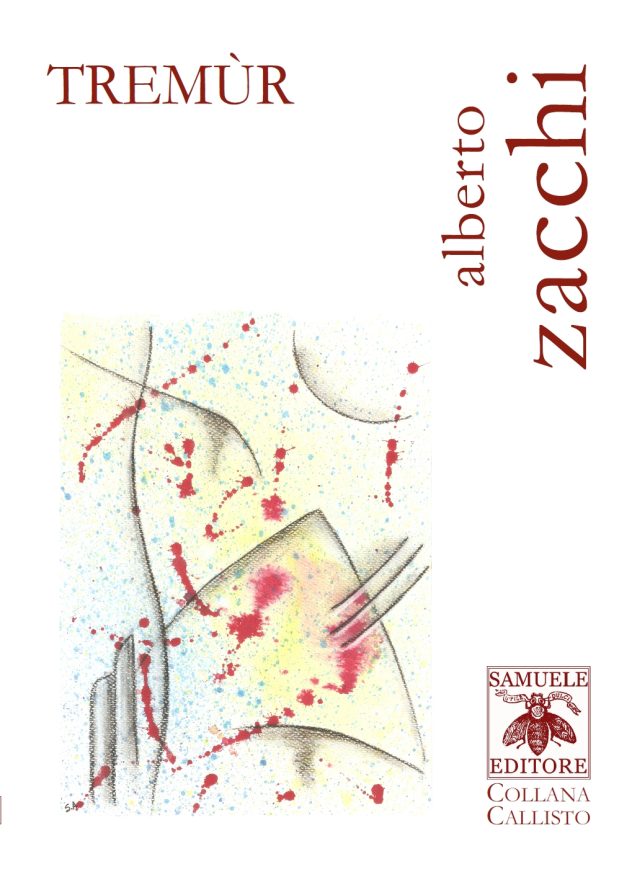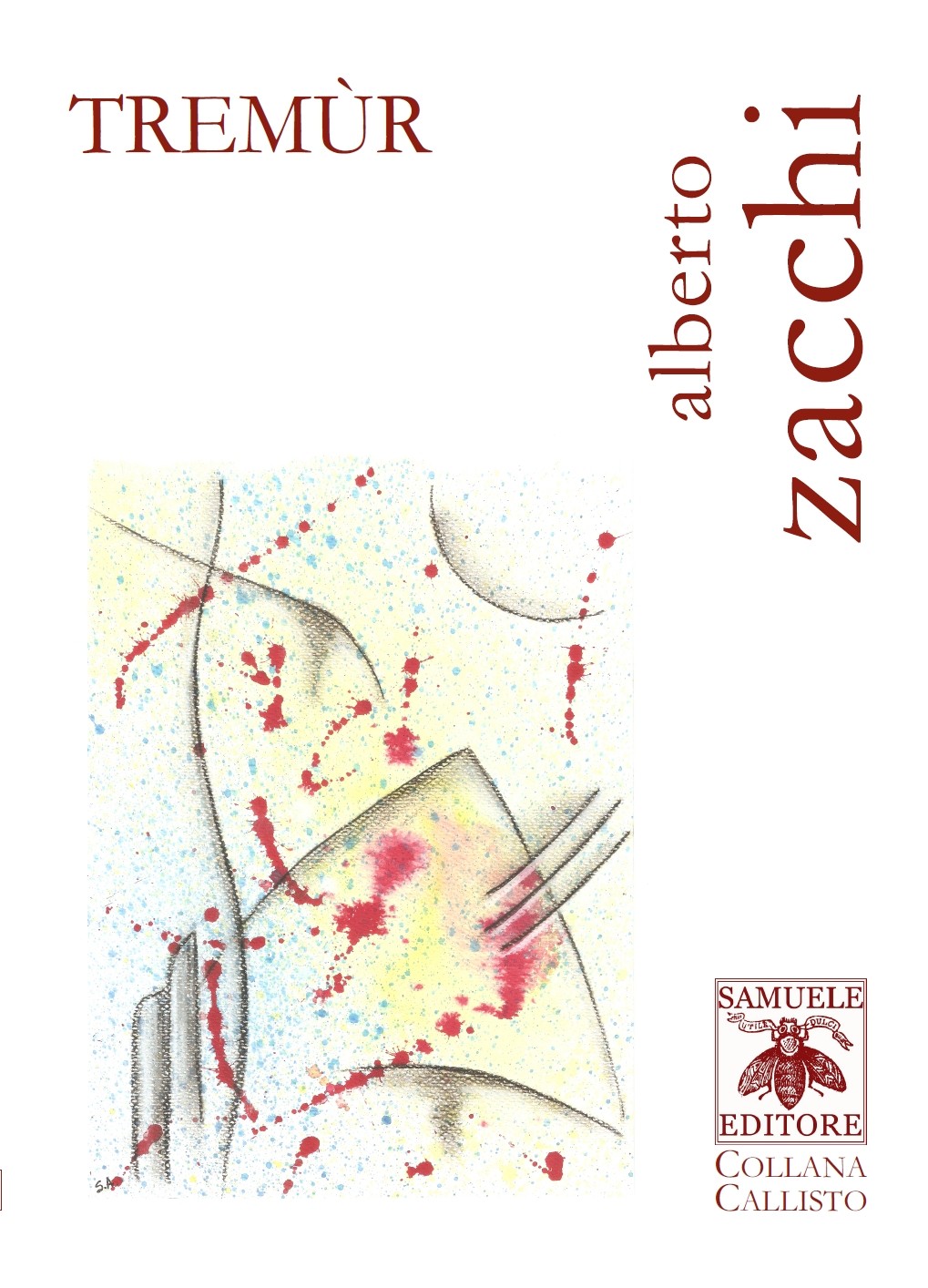
da Sololibri
Alberto Zacchi, poeta, regista, uomo di teatro, fine dicitore alla maniera dei trovatori (recita negli incontri letterari, sia in biblioteche che in chiesa), ha scelto il dialetto di Flero (Brescia) come forma espressiva. Con la raccolta Tremùr (Samuele editore, 2021, prefazione di Franca Grisoni, pp. 196) è vincitore del “Premio Bologna in Lettere 2021”.
Zacchi contraddice il pregiudizio di Croce secondo il quale la poesia popolare e/o dialettale non avrebbe dignità di poesia, in quanto non esprimerebbe i moti superiori dell’anima. Con tale visione Croce dimostra di non essere poeta, mostra l’aridità a cui può giungere un filosofo se stacca il pensare dal sentire. Zacchi sa cosa sia il sentire nella maniera più totale e possiede la capacità di rappresentarlo in un modo così intenso da identificarsi nel dolore, e in certo senso nella condanna se ci si ferma soltanto in superficie, inflitta da una malattia che a poco a poco distrugge il corpo, facendolo tramare e poi fermandolo, fino a raggiungere la tragica consapevolezza e l’accettazione dell’ineluttabile:
“DISTÜRBÀ”
L’è chel distürbà / che sè volares mai dà / che dà fastide / quasi pö del tremà.”
(DISTURBARE
È quel disturbare / che non si vorrebbe mai dare / che dà fastidio / quasi più del tremare.)
Vi è nobiltà in tale percorso; il poeta lo compie insieme al malato, trasformandosi nel Cireneo della Quinta Stazione delle “Via Crucis”; intento non facile, compito che ciascuno dovrebbe imparare ad assolvere almeno in una certa misura. Non facile perché si potrebbe cadere nel pietismo, molto diverso dalla compassione (etimologicamente: patire con), ed è quanto Zacchi evita, restituendoci la verità con una poetica alta e partecipativa, di grande spessore etico e meditativo. Il pensiero va, per analogia, a Leopardi, a quelle sue tragiche parole ultime:
“Sono un tronco che sente e pena”.
Il male è il Parkinson, rivisitato con versi brevi, efficaci, icastici, spesso crudi, spesso di una dolcezza che soltanto il dolore irrimediabile conosce, di una sincerità disarmante; male condito anche di vergogna nel sentirsi inermi e in mani altrui, impossibilitati a compiere le funzioni vitali e i gesti consueti, ma versi anche pregni di una dignità che dovremmo tutti ritrovare:
“DIGNITÀ
Me ‘arde ‘nturen / e pòs dim fürtünat, / el mal el m’ha quasi copat, / ma ‘l m’ha mia caat el co, / el m’ha mia robat / la dignità.”
(DIGNITÀ
mi guardo attorno / e posso dirmi fortunato, / il male mi ha quasi ucciso, / ma non mi ha tolto la ragione, / non mi ha rubato / la dignità.)
Graziella Atzori
Continua su Sololibri