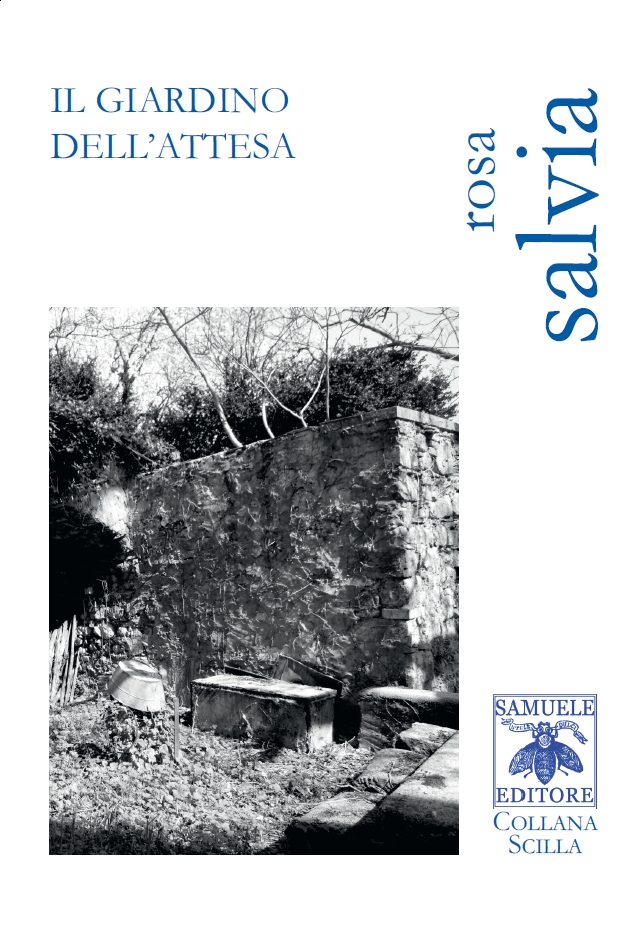
La poesia di Rosa Salvia è gentile e a suo modo fiabesca.
La fiaba è un genere letterario che, certo, non espelle dalle sue trame il dolore e le avversità, cosicché, leggendo questi versi dedicati all’attesa di un giardino, prima avvertiamo il fiabesco della primavera, la morbidezza delle forme, ma poi, a un certo punto, sovviene l’inverno, la bruma che stempera i colori, e così il clima cambia.
Il dolore è nello stato delle cose, certo. Rosa Salvia lo coglie osservando le persone che nell’antr’acte cittadino – questo è ogni giardino – lasciano parole e oggetti minimi della loro presenza, delle loro fragili storie.
Passano, andando a comporre altri luoghi, come gli animali evocati, ai quali le persone sensibili dedicano un’anima come si fa con i simili, i fratelli, cosicché noi non avvertiamo una differenza di stato tra la Luigina che “piange da sola / a stento muovendo le labbra”, p. 48, e il gatto di casa che “preferisce la pioggia al consueto riparo / di una stretta finestra di cucina”, p. 50.
Rosa Salvia svetta su queste figure come da una posizione alta, guardando e scrivendo da una finestra, sormontata a sua volta dalla presenza di una torre saracena che sembra avere la memoria più lunga di tutti. Una memoria, però, che non custodisce, perché solo alla poesia è dato di trapassare il dato storico, il dato spicciolo della materia nel dato ineffabile di una nuova realtà che ci attraversa tutti.
Sebastiano Aglieco
Continua su Compitu re vivi

