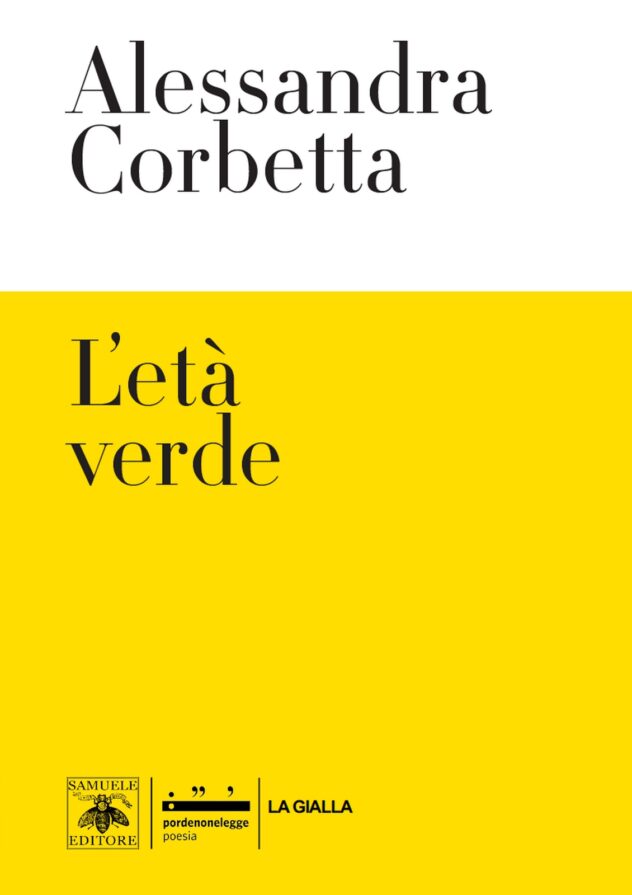Continua su Rivista Clandestino
Il lettore mi faccia credito di delicatezza. Mai vorrei che queste poche righe, invece di muovere al pensiero e al turbamento, ferissero qualcuno. Ma la materia è delicata, e non può che esserlo quando la conversazione sulla poesia invece di rimanere sulle superfici, o persino sui convenevoli, scende a toccare midolla, ventre, cuore, anima.
Appaiono sempre più spesso favolose bambine nelle raccolte di alcune non più giovanissime poetesse italiane. Ad esempio nei recenti libri di Eva Laudace e Alessandra Corbetta, ma anche nella Leardini e nella Colella e qua e là altrove. Senza dimenticare le prove poetiche e narrative antecedenti di Lucrezia Lerro. Appaiono con le ovvie differenze e con diversi gradi di costruzione e riuscita (ad esempio un poemetto teatrale quello della Laudace, una sezione invece in Corbetta, disseminate in altre). Un altro poemetto sulla bambina – infine espunto – era anche nel libro ultimo di Alessia Iuliano. E altre bambine troviamo adombrate nei versi della Leardini e di altre come Mussoni. Un caso? Forse. Una tendenza? Beh, gli antecedenti ci sono, da “Piccole donne” in poi, ma non mi pare che tra le poetesse del passato ci fosse questa mitizzazione dell’infanzia. Mito tremendo va detto subito, perché non parliamo certo di rappresentazioni di fanciulle dalla vita melliflua, vite che però la distanza d’anni certo carica o rilegge – non solo nel segno di Freud – come gravide di segni e ferite e presagi. Insomma, una tendenza mitizzante. Intendo che in tale mitizzazione dell’infanzia femminile da parte delle poetesse – ripeto, ognuna con voce diversa – va forse letta una questione che nella nostra società vive e riverbera anche in altre questioni e campi. La questione meriterebbe ben altro approfondimento, ma in luoghi diversi, con segnali distanti ma convergenti a quanto in queste poesie si dice e non dice – ad esempio le crescenti patologie legate alla percezione del corpo, le ansie di abbandono che diventano allarmi continui e patologizzati, o le percentuali nettamente più alte in campo femminile di richieste di transizione sessuale. Siamo di fronte a una difficoltà di accettazione della femminilità? Esplode nella mente questo singolare ma non aleatorio interrogativo. Ovviamente, in campo poetico il ricorso mitico a una zona della propria vita pre-sviluppo può avere molte ragioni, e essere una indagine sulla mappa di traumi o silenzi maturati nel “bosco” delle relazioni (anche il bosco torna spesso nelle pagine di queste Cappuccette Rosse). Ma non può interrogare il fatto che non mi pare avvenga cosa analoga in campo maschile.
Davide Rondoni
Continua su Rivista Clandestino