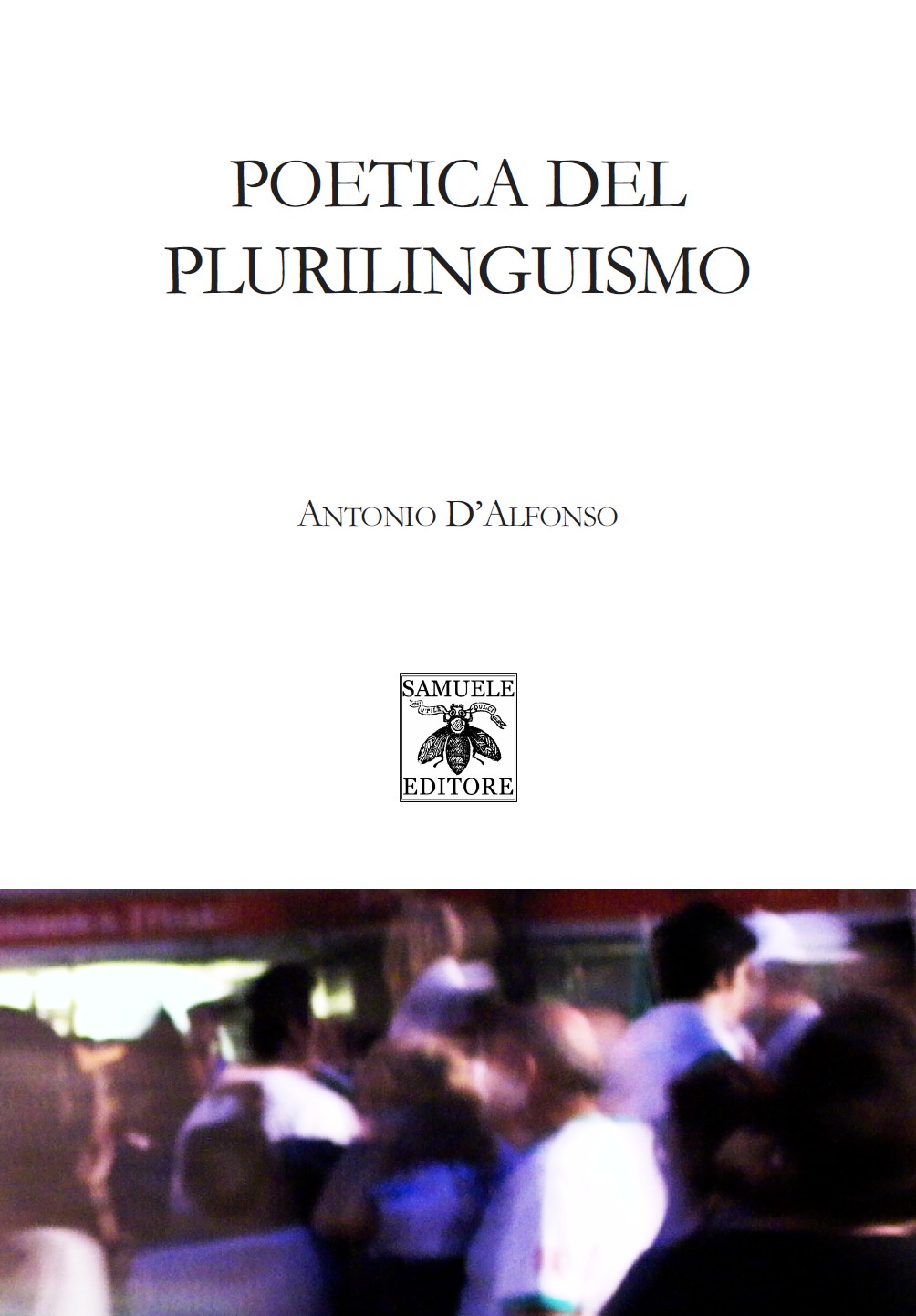
Antonio D’Alfonso, Poetica del plurilinguismo, Samuele Editore, Fanna (PN), 2015, pp. 62, euro 12
Quanto scrivere “tra le lingue” connota la produzione dei nuovi poeti contemporanei, quelli che si sono trovati a vivere una vicenda di migrazione e devono fare scelte linguistiche opportune alla propria vena creativa e all’ascolto delle proprie opere? Tema quanto mai interessante questo sollevato da Antonio D’Alfonso, nato a Montreal (dove vive) da genitori abruzzesi che parlano un dialetto originario, scolarizzato in inglese, poi la scelta di scrivere in francese e in inglese per accrescere la possibilità di diffusione dei suoi lavori. Scelta non indolore, meditata (“«Perché non scrivi in italiano?» mi chiedono spesso. La mia risposta è semplice: – «Perché!». Per la stessa ragione per cui scrivo in francese. Si scrive nella lingua che è sentita dalla propria comunità.”). Una scelta che apre una serie di interrogativi di pressante attualità, apre scenari impensati precedentemente, visto il mondo globalizzato in cui viviamo e viste le migrazioni sempre più diffuse nelle diverse parti del mondo, con i conseguenti mescolamenti di popoli, lingue, culture, per cui il rapporto originario con una sola lingua può diventare “debole”, non più fondante in assoluto di una scrittura letteraria.
Se non si usa nella scrittura pubblica la propria lingua di provenienza si abbandona una cultura, la si tradisce? si interroga D’Alfonso. La risposta è no, si appartiene a una cultura (nel caso specifico quella italiana), anche se se ne usa la lingua solo per comunicazioni che attengono alla sfera privata. Perché il riferimento e l’appartenenza a una cultura, a una tradizione è qualcosa di più complesso e ricco del solo uso della lingua. Utile il riferimento a Ovidio che l’autore propone: “Non è la lingua latina che mi permette di sentire, reagire a ciò che scrive Ovidio. Il punto di congiunzione tra interno(sé) ed esterno (l’altro) in Ovidio mi affascina o, piuttosto, mi fa vibrare”. Da qui parte un elogio della traduzione “unico traghetto che può condurre da un centro all’altro”, fondamentale per una relazione a più voci e una circolazione di opere di scrittura nella contemporaneità. E da qui l’appello ai giovani, soprattutto, a non rinchiudersi in una unica tradizione ma osare anche una lingua altra, diversa da quella parlata.
Ed ecco subito una seconda questione, questa volta preoccupante. Nei paesi di lingua anglofona e generalmente di cultura americana si traduce poco e quando le traduzioni esistono non destano interesse, cadono nell’indifferenza. Come se la cultura di riferimento da cui quel determinato testo è stato tradotto non riguardasse il pubblico, gli addetti ai lavori. Oppure si loda lo stile della traduzione quando è bella, a scapito dell’ascolto del messaggio del testo tradotto. È la caduta del multiculturalismo che resta soltanto una operazione politically correct, senza effetto alcuno.
Per uscire da questa impasse Antonio D’Alfonso propone una figura-modello di autore interessante: l’autore ostinato. Rifiutando sia il silenzio sia l’indifferenza indica nella ostinazione, nella perseveranza, nella forza di spirito a continuare il proprio lavoro senza preoccuparsi “dell’accoglienza riservata alle sue parole” il compito da perseguire. Perché il nuovo modello di autore che sta emergendo oggi è un autore che appartiene, sente di appartenere, a più culture, anche se non usa tutte le lingue ufficiali di queste culture nella propria produzione letteraria. Un autore che transita, ha transitato da un luogo all’altro, perché come ricorda l’autore “l’emigrazione è la regola non l’eccezione”. Così D’Alfonso sente di appartenere alla cultura italiana ma anche a quella inglese, francese. Come classificare questi nuovi scrittori? Dove collocarli, in quale tradizione culturale, se ha senso farlo? È chiaro che si propone una ridefinizione, una ridiscussione delle categorie, dei modelli, dei canoni. “Il poeta strappa il diritto di parola anche quando non scrive nella lingua della nazione”. Sono proprio gli scrittori che hanno questa posizione a-topica a cui va l’ammirazione di D’Alfonso.
Altro punto interessante della discussione, dato tra le righe ma inevitabilmente presente, è il grande tema dell’autotraduzione, questione già dibattuta in diversi luoghi e lavori, e che non sempre trova pareri concordi, anche se l’autotraduzione è stata esercitata nel tempo e nelle diverse letterature da numerosi scrittori e poeti.
Nel secondo saggio del volumetto si entra nel vivo del tema delle identità, delle nazioni, delle culture. Con una osservazione interessante: “Parlare della purezza della cultura è un paradosso: una cultura pura non esiste, la cultura è contaminata”. E più sotto: “La cultura è sempre la combinazione di culture diverse. La cultura è necessariamente pluralista”. Anche questi sono temi di stretta attualità, largamente dibattuti nelle diverse letterature e in particolare in quelle letterature che generalmente si definiscono della migrazione. Qui l’autore dopo aver fatto una veloce e utile carrellata storica sui concetti e le definizioni di nazione, stato, territorio, patria, entra nel vivo del dibattito rilevando come è proprio nelle terze generazioni della migrazione che questi argomenti diventano cruciali. Con autori che si trovano a fare i conti con le culture di provenienza e quelle acquisite nel transito. E la scelta di Antonio D’Alfonso decisamente si colloca in una dimensione pluriculturale in cui le culture stesse “si liberano dal territorio” per un nomadismo denazionalizzato, un transnazionalismo plurale senza centralizzazione di lingua, etnicità e religione, una sorta di spazio immaginato che esisterà se noi lo vogliamo. Ma su questo ultimo punto, a mio parere piuttosto utopico, ci vorrebbero ulteriori approfondimenti.
Gabriella Musetti

