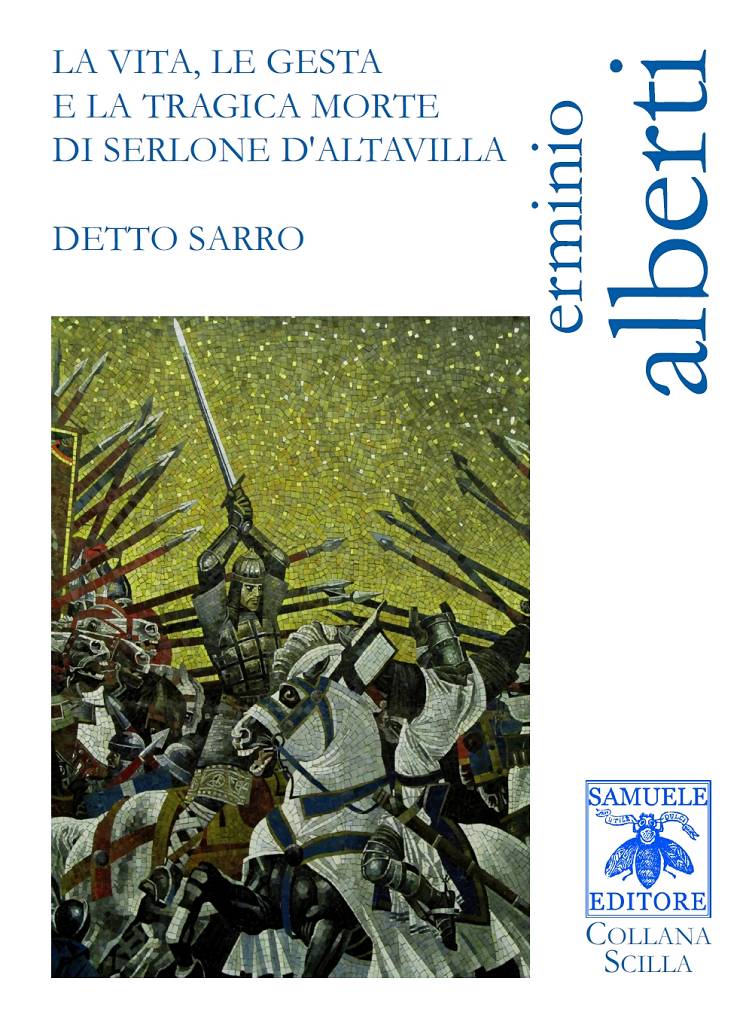
Marguerite Yourcenar, nel suo memorabile “Pellegrina e straniera”, scrisse così dei pupi siciliani: “[…] sono sublimi: sono l’eroismo, la fedeltà, gli angeli presenti e Dio svelato.” Si può dire la stessa cosa dell’ultimo libro di Erminio Alberti, La vita, le gesta e la tragica morte di Serlone d’Altavilla, detto Sarro, che da una tale tradizione, ricca e complessa, prende nutrimento. A partire da un’antica cronaca normanna dell’XI secolo, Alberti reinventa – o meglio, ricolloca nella contemporaneità –, quest’antica vicenda, inscenandola come se si trattasse di una rappresentazione teatrale, sostituendo alle aste del puparo una solida ricerca linguistica, il risultato della quale è un linguaggio prezioso, canoro ma non desueto, che potrebbe ricordare (ma non per facili parallellismi geografici, essendo Alberti siculo) quello di poeti come Piccolo, alle estremità libere e lucenti della poesia italiana. Ad ogni modo, è questo il solo registro adatto alla poetica di Alberti, che in questa raccolta tocca tematiche gravose quali la perdita dell’identità culturale/personale, la difficoltà nel ricrearsene un’altra ex novo, il progressivo arrugginirsi persino di un’età del ferro volgare e disperante, e infine (forse il vero fulcro dell’opera), l’incapacità di prendere atto, volenti o nolenti, di verità che emergono in tutta la loro brutalità…
Ma andiamo con ordine. La raccolta si apre in medias res, con versi che fanno da sprone in una situazione disperata ([…] celebreremo di nuovo il nostro amore / per Europa la bella, che sta per morire), e che evocano al sottoscritto le atmosfere del Cornet di Rilke (uno dei pochi precedenti, si parva licet, a questa silloge). Segue una dichiarazione di poietica (il titolo della sezione è proprio questo), che fa le veci di libretto di istruzioni a ciò che si andrà a leggere, e che tra professioni di fede nella parola e nel dubbio (in una contemporaneità così sovraccarica di immagini e “certezze”) e suggestioni crepuscolari, può essere riassunta in questi versi: “Raccogliere un lauro sfrondato / dall’umido greto, mezzo infangato / – avere il coraggio di prenderlo, / pigiarselo in testa / ci vuole la faccia […]”. Il coraggio – dettato dal dovere – di farsi cantore, sacerdote, in un’epoca che ha sputato su qualunque forma di sacralità, confessionale o meno che sia.
Segue la sezione che dà il titolo all’opera, nella quale, alla vicenda di Serlone, troviamo intrecciate rielaborazioni istintuali dei generi della poesia cortese: il racconto di guerra, la descrizione di cose piacevoli e dell’amata, della caccia… tutto però è vestigia, cosa precaria, e quindi sfuggente e nostalgica, oltre che fatalmente caduca. Qui inoltre troviamo i versi che sono un po’ il fulcro di tutta l’opera: “[…] ecco che il cielo si squarcia, / si strappa come di carta / pesta, si mostra l’inganno – ed è un guizzo / dell’occhio – / ma intanto / la lotta imperversa […]”).
Nel Kali Yuga, la sezione successiva, fa riferimento a ciò che nelle Sacre Scritture Hindu è riconducibile alla nostra concezione di età del ferro. In scenari di consumismo post-apocalittico ([…] giacché ha dato i suoi frutti / la grande omologazione. […]) e auspici di rivincita ([…] Vibra il sacro canto dei figli della terra: / un giorno muoveranno gli animi alla guerra), Alberti sembra fare sua la disperazione che già fu di Pound nel Cantos XLV, With Usura: nell’ultima lirica che chiude questa sezione, Alberti infatti scrive: “[…] Non più ti farà libero il lavoro / il giorno che il lavoro più non crea / ma il pane dei fratelli prende e assale”.
La silloge continua con Siciliae, che raccoglie le atmosfere desolate della precedente sezione ma modulandole in chiave più dolce e nostalgica perché riferite alla terra natia di Alberti, la Sicilia appunto, e in particolare la zona dei Nebrodi (terra che ha dato i natali anche al nostro Di Bernardo Amato), uno dei luoghi, malgrado tutto, ancora intatti della Sicilia in termini di tradizioni e suggestioni antiche. Un patrimonio che, pur percependolo come scrigno immutabile (“[…] scrigno di memorie impronunciabili / e di destini immutabili / quale sei / – quale sono, e fui […]”), Alberti non si limita a contemplare languidamente, ma spera che possa trovare un rinnovamento, seppur in una sorta di eterno ritorno ([…] torneranno tra i monti quei cerbiatti / di nuovo poi il canto potranno udire[…]), più simile ad una concezione classica e circolare della vita che ad una in senso illuministico-positivista. Fanno la loro comparsa anche una manciata di poesie in dialetto, a ulteriore puntello (e maschera, come anche l’opera di Marin ci ha insegnato) dell’io poetico immerso nella sua terra. Qui il linguaggio diventa arso, più diretto e asciutto, come sempre capita nei dialetti, e sembra quasi che nella maschera dialettale Alberti si tolga quella del narratore manieristico e sapiente fino a questo punto indossata (o forse la vada ad arricchire).
Nottetempo, l’ultima sezione, chiude e allo stesso tempo proietta la silloge in maniera coerente rispetto a tutto ciò che fino a qui si è detto (“[…] e il punto non è l’andare / ma il non voler ritornare.”), ma senza perdere la sua struggente natura di congedo e di riflessione sulla fine (di qualunque tipo essa sia) che ad ogni congedo è annessa (“[…] che è giunta sera ed ogni tuo affetto / dorme già da tempo, / e devi andare a letto.”). Il sipario si chiude, il cavaliere saluta la sua donna e si incammina (“[…] serrando / le cinghie della sella / o l’ultimo bottone del paltò. / Addii, mia bella / per quante volte quest’uomo si voltò.”).
Non si faccia l’errore di giudicare questo libro come un’opera dal gusto antiquato e inconciliabile con le esigenze di linguaggi contemporanei (ma non ci è forse contemporanea anche l’antichità, per il solo fatto di essere presente ai nostri occhi?): qui siamo davvero davanti ad un esempio di ricollocamento e di cortocircuito dell’antico con il moderno, operazione legittima e assolutamente attuale; prima di tutto dal punto di vista della ricerca linguistica, che nel suo incedere lento e profondo davvero si pone come un convincente tentativo, parafrasando Adorno, di realizzare le speranze del passato senza cadere nella musealità. Certo, fermandosi alla superficie può non essere un libro per tutti, vuoi per la cremosità del linguaggio (vista ingenuamente come cosa retrò), vuoi per i riferimenti lontani dal quotidiano: ma leggendolo ci si accorge come le tematiche trattate siano drammaticamente, urgentemente attuali, e come il modo più efficace per esprimerle sia proprio quello usato da Alberti: il canto.

