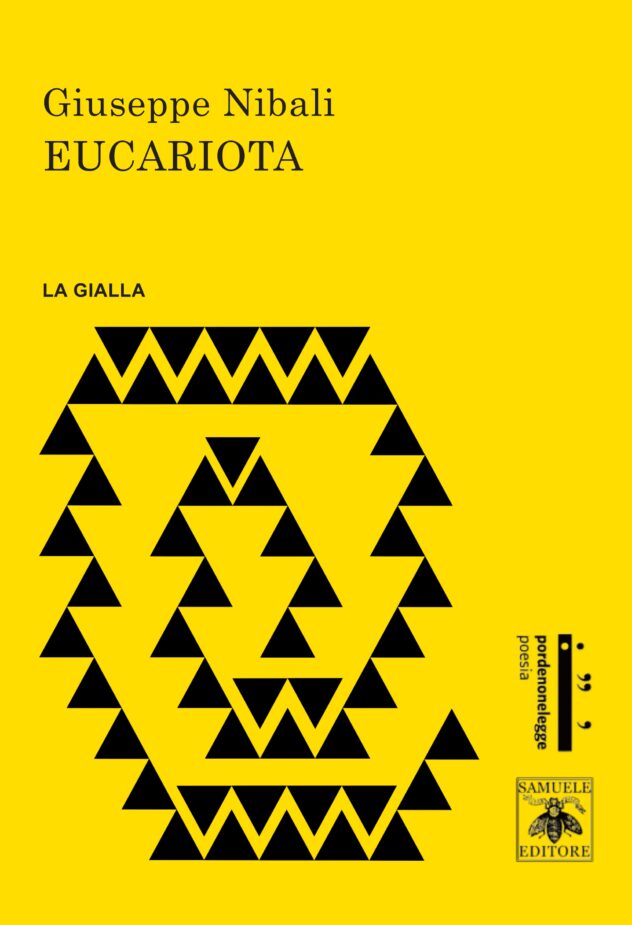da L’Estroverso
«Nel mondo che si muove ed è vivo». Nel mondo che «non incide più i nomi dei suoi morti/ sui marmi». Andando alla radice, per «riportare alla vita ciò che è nascosto». Perquisendo nel dubbio, «tutti di stare vivendo il nostro male». Guardando “l’altrove” con gli occhi accesi sul presente (anche dal “passato”). Catturando il reale, nel tramaglio di immagini nude. Acute. Udendo un tempo «esistito e incalcolabile». Un tempo «miserabile». Spingendo «il profumo del niente dentro al petto». “Muove” così, il catanese Giuseppe Nibali, autore di “Eucariota”, nuovo “pungente” libro in versi pubblicato nella collana “La Gialla”, a cura di Alessandro Canzian, Roberto Cescon, Augusto Pivanti e Gian Mario Villalta, progetto culturale di “Pordenonelegge” in collaborazione con “Samuele Editore”. La nostra breve intervista, intorno all’esperienza (tangibile) del “tempo”.
Qual è stata la scintilla – forse meglio la “stella” – che ha portato il tuo “Eucariota”, meglio: in che modo la (tua) vita diventa linguaggio?
Eucariota nasce come superfetazione di Scurau, il libro che ho pubblicato con Arcipelago Itaca nel 2021 e che in un certo modo ha cambiato il mio modo di scrivere. Scurau era figlio di un lavoro di anni, di studi, di letture. Pubblicarlo è stato togliermi un peso ma anche inaugurare una fase molto prolifica della mia produzione letteraria. A Scurau hanno fatto seguito Animale ed Eucariota, più il romanzo a cui sto lavorando adesso. Questo testo è invece venuto fuori con maggiore naturalezza, e ad alcuni la cosa piace. Ha ricevuto, paradossalmente, una critica migliore rispetto a quella di Scurau. Ci ho lavorato per due anni, anni in cui sono stato in giro per l’Italia a presentare, ho avuto meno tempo per leggere e per scrivere. Credo dunque che tutto sia venuto in modo più spontaneo, più vero, in un certo senso. Se Scurau raccontava la disgregazione di una società e la sua rinascita in chiave rurale e degenerata (nell’accezione migliore) questo testo forse torna alla lirica, solo che qui chiunque (e qualunque cosa) può dire “io”. Ne viene fuori una serie di punti di vista differenti sulle cose del mondo. Parlano qui gli alberi, gli animali, i figli, gli uomini, le donne. Raccontando però sempre ciò che deve a mio avviso essere raccontato, e quindi il dolore di vivere, la sofferenza, ma anche la rabbia, la violenza, l’amore folle per questa cosa che è essere viventi.
La poesia è un destino?
È una domanda strana. Non per come è posta ma per come reagisce in me. Avrei risposto: No, che non lo credo assolutamente. Eppure penso che quando un bambino cresce in casa di un pittore sviluppi poi un rapporto con i colori, con gli olii, con i pennelli che ad altri, arrivati dopo, sfugge. Allo stesso modo mi pare di essere cresciuto come un privilegiato, con mio padre che mi avvicinava la sedia alla scrivania e intanto leggeva Virgilio, in latino. Mentre io bambino scrivevo e pasticciavo fogli su fogli, con l’inchiostro che era la mia tempera e la penna che era il pennello. Mia madre mi faceva dipingere, mio padre mi riempiva la testa di storie, di racconti di grandi battaglie, di Orlando e di Ulisse, dei tartari, di Agamennone che sacrifica Ifigenia. La sera mettevamo in scena la canzone di Orlando, in corridoio, sul cavallo a dondolo, con una Durlindana di legno, ricavata dal battiscopa. Questo mi ha formato, sicuramente. Per me era gioco, quello, ma non lo era, o meglio: non era solo un gioco. Quindi mi piacerebbe dire che non lo è, che nulla c’entra col destino, eppure capisco bene che senza quell’infanzia difficile per me sarebbe stato diventare uno scrittore. Sicuramente avrei cercato una modalità espressiva, addirittura artistica, ma chissà quale.
Grazia Calanna
Continua su L’Estroverso